«Non andartene docile in quella buona notte. I vecchi dovrebbero bruciare e delirare al serrarsi del giorno; Infuria, infuria, contro il morire della luce. Benché i saggi conoscano alla fine che la tenebra è giusta Perché dalle loro parole non diramarono fulmini Non se ne vanno docili in quella buona notte, I probi, con l’ultima
 «Non andartene docile in quella buona notte.
«Non andartene docile in quella buona notte.
I vecchi dovrebbero bruciare e delirare al serrarsi del giorno;
Infuria, infuria, contro il morire della luce.
Benché i saggi conoscano alla fine che la tenebra è giusta
Perché dalle loro parole non diramarono fulmini
Non se ne vanno docili in quella buona notte,
I probi, con l’ultima onda, gridando quanto splendide
Le loro deboli gesta danzerebbero in una verde baia,
S’infuriano, s’infuriano contro il morire della luce».
Dylan Thomas, Do not go gentle into that good night (1951)
Sono i versi del gallese Dylan Thomas, affascinante neo-romantico attivo a New York nella prima metà del secolo scorso, a insufflare poesia sul nuovo capolavoro firmato Christopher Nolan. Il visionario regista inglese, dopo aver sbancato i botteghini con l’ultimo capitolo della saga de Il cavaliere oscuro, e terminata l’esperienza alla produzione esecutiva di L’uomo d’Acciaio per la regia di Zack Skyder, ritorna sui grande schermi con una pellicola che strizza l’occhio al kolossal movie (165 milioni di dollari di budget), mantenendo però la qualità e la genialità che sin dal primo lungometraggio (Following, era il lontano 1998) lo contraddistinguono. Dopo la più che riuscita impresa di rivitalizzazione del franchise Batman, da buon scienziato del cinema Nolan accoglie la lezione di Thomas e “does” not go gentle into that good night. Risultato, un’opera grandiosa, un viaggio immaginifico alla ricerca di un nuovo luogo per la vita, l’anelito alla fuga dalla morte. Sono allora l’imperativo categorico della speranza, lo spirito “universale” (non il solito “titanismo” patriottico americano) della scoperta, il coraggio di vivere a parlare in Interstellar. Il desìo kantiano che porta l’uomo ad abbracciare le stelle, a volare dal «legge morale» alla «cielo stellato».
Ancora rivoluzionaria la trama, la visione di un cineasta-ingegnere che si muove tra scienza e fantascienza, realtà e sogno.
Un piaga sta uccidendo i raccolti della Terra, da diversi decenni l’umanità è in crisi da cibo e quasi tutti sono diven tati agricoltori per supplire a queste esigenze. La scienza è ormai dimenticata e anche ai bambini viene insegnato che l’uomo non è mai andato sulla Luna, si trattava solo di propaganda. L’ex astronauta Cooper (Matthew McConaughey), mai andato nello spazio e costretto a diventare agricoltore, scopre grazie all’intuito della figlia che la NASA è ancora attiva in gran segreto, che il pianeta Terra non si salverà, che è comparso un wormhole vicino Saturno in grado di condurli in altre galassie e che qualcuno deve andare lì a cercare l’esito di tre diverse missioni partite anni fa. Forse una di quelle tre ha scoperto un pianeta buono per trasferire la razza umana e in quel caso è già pronto un piano di evacuazione. Andare e tornare è l’unica maniera che Cooper ha di dare un futuro ai propri figli (fonte: mymovies.it).
tati agricoltori per supplire a queste esigenze. La scienza è ormai dimenticata e anche ai bambini viene insegnato che l’uomo non è mai andato sulla Luna, si trattava solo di propaganda. L’ex astronauta Cooper (Matthew McConaughey), mai andato nello spazio e costretto a diventare agricoltore, scopre grazie all’intuito della figlia che la NASA è ancora attiva in gran segreto, che il pianeta Terra non si salverà, che è comparso un wormhole vicino Saturno in grado di condurli in altre galassie e che qualcuno deve andare lì a cercare l’esito di tre diverse missioni partite anni fa. Forse una di quelle tre ha scoperto un pianeta buono per trasferire la razza umana e in quel caso è già pronto un piano di evacuazione. Andare e tornare è l’unica maniera che Cooper ha di dare un futuro ai propri figli (fonte: mymovies.it).
Uscito negli States lo scorso 5 novembre, e il giorno immediatamente successivo in Italia, Interstellar divide critica e pubblico. Importante, su entrambi i versanti, il caso Kubrick. Molti, infatti, sono coloro che hanno denigrato la creazione di Nolan, non solo per la difficile comprensione e le incongruenze di sceneggiatura (evidente qualche plot hole, buchi nella trama, ellissi narrative: basti pensare a una società ormai morente e senza industrie che continua a bere birra in bottiglia o avere della carne pur con allevamenti animali che sembrano scomparsi), la lentezza della porzione introduttiva, la grande perizia tecnica sfoggiata nei discorsi pedagogici degli scienziati che però non manca di mantenere incollati allo schermo i più appassionati.
A far gridare all’eresia è invece il paragone col mostro sacro Kubrick e il suo 2001: Odissea nello spazio, indiscusso capolavoro fantascientifico, tassello imprescindibile della cinematografia novecentesca, con cui Nolan si cimenta, per alcuni prometeicamente. Certo, notevoli sono i debiti contratti con cinema e letteratura fantascientifica. Ad esempio, ricordano Kubrick la danza nello spazio delle astronavi (questa volta accompagnata dalle musiche del pluripremiato maestro tedesco Hans Zimmer), la caduta nel buco nero e il passaggio in un’altra dimensione dove spazio e tempo collassano. Si aggiunga poi Ridley Scott e l’intramontabile Alien, vistosamente citato nelle scene girate all’interno della navicella, che tanto ricordano Sigourney Weaver e le sue claustrofobiche avventure alla scoperta del mostro. Evidente poi quanto Nolan si senta figlio di Isaac Adamov, padre della robotica: il monolito nero impenetrabile del film di Kubrick si riduce in TARS e CASE, i due robot parlanti della spedizione spaziale.
debiti contratti con cinema e letteratura fantascientifica. Ad esempio, ricordano Kubrick la danza nello spazio delle astronavi (questa volta accompagnata dalle musiche del pluripremiato maestro tedesco Hans Zimmer), la caduta nel buco nero e il passaggio in un’altra dimensione dove spazio e tempo collassano. Si aggiunga poi Ridley Scott e l’intramontabile Alien, vistosamente citato nelle scene girate all’interno della navicella, che tanto ricordano Sigourney Weaver e le sue claustrofobiche avventure alla scoperta del mostro. Evidente poi quanto Nolan si senta figlio di Isaac Adamov, padre della robotica: il monolito nero impenetrabile del film di Kubrick si riduce in TARS e CASE, i due robot parlanti della spedizione spaziale.
Insomma, un’inversione di tendenza per il cinema hollywoodiano, che porta sul grande schermo l’audacia di un regista che fa i conti con la storia, in un rapporto di imitazione-emulazione col modello fantascientifico che ancora una volta lo vede vincitore. Merito? Quello di riuscire a coniugare le ragioni del blockbuster dai grandi investimenti produttivi con le istanze autoriali. Perché, anche nello spazio, anche nella quarta e nella quinta dimensione, Nolan rimane se stesso, completamente.
Ingegnere della mente, il regista britannico da sempre costruisce i suoi personaggi tra mistero e menzogna. In questo Cooper è l’ennesima variante del protagonista senza memoria di Memento, dell’Al Pacino senza sonno in Insomnia, dei maghi Bale e Jackman di The Prestige, del Di Caprio «ingegnere di sogni» in Inception, nonchè del misterioso giustiziere mascherato della trilogia de Il Cavaliere Oscuro. Coraggioso nel rinunciare alle pompose overture da “viaggio spaziale” (alla Armageddon, per intenderci) per collocare lo spettatore in medias res, nel vivo dell’azione. Inoltre il singolare uso narrativo del tempo. Interstellar diventa la mirabile prova di come il cinema possa raccontare, intrecciare storie attraverso la sovrapposizione di temporalità diverse: il tempo degli astronauti da un lato, quello degli abitanti della terra dall’altro. Due tempi, due dimensioni che però, pur svolgendosi ad anni luce di distanza, riescono a dialogare e comunicare, facendo dei protagonisti (Matthew McConaughey e Anne Hathaway, eccellenti interpreti) gli archetipi di un’umanità che non si arrende, non smette di osare. E lo fa andando oltre l’eroismo individuale che caratterizza tanta cinematografia americana, spesso anche premiata dall’Academy.
Sapienza e originalità narrativa ancora messe al servizio della scienza, in modo decisamente nuovo però. Se infatti tautologica o eccessivamente lacrim osa può sembrare la storia d’amore, evergreen del cinema hollywoodiano che diventa principio metafisico, aristotelico motore immobile di tutto lo sviluppo drammaturgico nella sceneggiatura scritta a quattro mani insieme al fratello Jonathan (l’amore familiare e quello filiale tra padre e figlia; l’amore di Amelia Brand-Anne Hathaway, che ricorda la dottoressa Stone di Gravity di Alfonso Cuaron); molto più affascinante è la messa in scena delle teorie sull’esistenza dei wormhole, tunnel spazio-temporali che permettono di viaggiare tra una galassia e un’altra, e che si appoggiano sull’astrofisica di Kip Thorne (tra i produttori esecutivi, oltre che consulente scientifico del film), la teoria della relatività, la criogenia. Una maestria narrativa da brividi insomma, che nella vicenda spaziale privilegia non la testimonianza dell’esistenza di forme di vita “altre”, ma la meraviglia, lo stupore di fronte alla possibilità di legare visioni trascendenti, metafisiche, con una concezione puramente scientifica della realtà. L’apertura a spazi di esistenza che vanno oltre l’umana, certificata tridimensionalità. La sublime scoperta di considerare il tempo “la” dimensione, di avere veri contatti con momenti storico-temporali all’apparenza lontanissimi.
osa può sembrare la storia d’amore, evergreen del cinema hollywoodiano che diventa principio metafisico, aristotelico motore immobile di tutto lo sviluppo drammaturgico nella sceneggiatura scritta a quattro mani insieme al fratello Jonathan (l’amore familiare e quello filiale tra padre e figlia; l’amore di Amelia Brand-Anne Hathaway, che ricorda la dottoressa Stone di Gravity di Alfonso Cuaron); molto più affascinante è la messa in scena delle teorie sull’esistenza dei wormhole, tunnel spazio-temporali che permettono di viaggiare tra una galassia e un’altra, e che si appoggiano sull’astrofisica di Kip Thorne (tra i produttori esecutivi, oltre che consulente scientifico del film), la teoria della relatività, la criogenia. Una maestria narrativa da brividi insomma, che nella vicenda spaziale privilegia non la testimonianza dell’esistenza di forme di vita “altre”, ma la meraviglia, lo stupore di fronte alla possibilità di legare visioni trascendenti, metafisiche, con una concezione puramente scientifica della realtà. L’apertura a spazi di esistenza che vanno oltre l’umana, certificata tridimensionalità. La sublime scoperta di considerare il tempo “la” dimensione, di avere veri contatti con momenti storico-temporali all’apparenza lontanissimi.
La forza di andare avanti, aldilà della cieca fede nell’infinitezza delle risorse del nostro pianeta. Una conclusione triste se vogliamo, ma audace in quanto capace di gridare la propria sofferenza, esprimere la propria rabbia, quella «rabbia contro il morire della luce», di cui parla Thomas. Perché è questo l’umanesimo scientifico di Nolan: la catastrofe globale, l’eroe che determina il cambiamento, il viaggio spaziale verso l’esterno alla ricerca di una nuova dimensione ontologica; le prove da affrontare lungo il viaggio, il sacrificio estremo dell’eroe-martire per la salvezza della propria famiglia, della propria razza, non del pianeta. Perché «la fine della terra non sarà la nostra fine».
Dopo aver giocato con la memoria, dopo aver attraversato il mondo onirico, Nolan riesce a confezionare un’altra opera d’arte. Un cast stellare (oltre ai già citati McConaughey e Hathaway, si contano Micheal Caine, Jessica Chastain, Matt Damon) illuminato dalla regia di un abile tessitore di trame e aggressivo sostenitore degli effetti speciali fisici e della pellicola al posto del digitale. Un’ode al cosmo. Un canto all’esplorazione. Un grandioso spettacolo visivo. Una riflessione su chi vogliamo essere come persone e come specie. Un viaggio nel futuro dell’uomo, più che nel futuro del pianeta.
Un’ode al cosmo. Un canto all’esplorazione. Un grandioso spettacolo visivo. Una riflessione su chi vogliamo essere come persone e come specie. Un viaggio nel futuro dell’uomo, più che nel futuro del pianeta.
Abbandonato l’inganno, svegliatici da un lungo sonno, ritorniamo a vivere. Non andiamo «docili in quella buona notte», ma infuriamo «contro il morire della luce». Pensiamo a quale destino vogliamo crearci.
Fuggiamo dal buio della morte. Troviamo una nuova luce.
Giuseppe Parasporo
[Fonti delle immagini: imdb.com; popoffquotidiano.it; soulstrut.com; hollywoodreporter.com; theatlantic.com; turntherightcorner.com; lightlybuzzed.com (copertina)]

















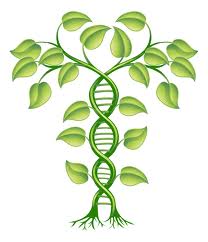





Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *