Nella primavera 2016, il Teatro Carlo Felice di Genova mise in scena con ottimo successo Roberto Devereux di Donizetti. A un anno di distanza, un altro titolo donizettiano di soggetto inglese – anche se è improprio individuare una trilogia in Anna Bolena, Maria Stuarda e Roberto Devereux – ha allietato i melomani liguri. La qualità
 Nella primavera 2016, il Teatro Carlo Felice di Genova mise in scena con ottimo successo Roberto Devereux di Donizetti. A un anno di distanza, un altro titolo donizettiano di soggetto inglese – anche se è improprio individuare una trilogia in Anna Bolena, Maria Stuarda e Roberto Devereux – ha allietato i melomani liguri. La qualità delle voci è stata, ancora una volta, esaltante; non si è invece visto, almeno alla recita domenicale del 21 maggio, tutto il pubblico che gremiva la sala un anno fa, e in platea abbondavano i posti vuoti. La ragione di questa defezione non va certamente ricercata nel titolo, ricco di fascino e più conosciuto del Devereux; probabilmente è un effetto del divismo che ancora connota parecchi appassionati di lirica: mancando un catalizzatore come il nome di Mariella
Nella primavera 2016, il Teatro Carlo Felice di Genova mise in scena con ottimo successo Roberto Devereux di Donizetti. A un anno di distanza, un altro titolo donizettiano di soggetto inglese – anche se è improprio individuare una trilogia in Anna Bolena, Maria Stuarda e Roberto Devereux – ha allietato i melomani liguri. La qualità delle voci è stata, ancora una volta, esaltante; non si è invece visto, almeno alla recita domenicale del 21 maggio, tutto il pubblico che gremiva la sala un anno fa, e in platea abbondavano i posti vuoti. La ragione di questa defezione non va certamente ricercata nel titolo, ricco di fascino e più conosciuto del Devereux; probabilmente è un effetto del divismo che ancora connota parecchi appassionati di lirica: mancando un catalizzatore come il nome di Mariella  Devia, diverse persone si perdono per la strada. E dire che la locandina della Stuarda non era certo carente di nomi che dovrebbero attirare l’attenzione di chi si interessa al primo Ottocento italiano!
Devia, diverse persone si perdono per la strada. E dire che la locandina della Stuarda non era certo carente di nomi che dovrebbero attirare l’attenzione di chi si interessa al primo Ottocento italiano!
Tanto per cominciare, la protagonista, il soprano Elena Mosuc: se c’è qualche spazio per perfezionare il sostegno del suono, l’intonazione risulta sempre perfetta e il fraseggio soppesato e intelligente. La cabaletta dell’aria d’esordio si è segnalata per il forte accento e per le marcate variazioni della ripresa, tese a sottolineare l’agitazione interiore della regina scozzese; la scena degli insulti per una fierezza che non sbraca mai in litigio da pescivendola. Nel II atto, la “confessione” si è distinta per la delicatezza del suono filato, associato al dolore del pentimento che si tramuta nella  certezza del perdono divino. La preghiera che segue – buona prova del Coro, compatto e coeso quale non lo si era percepito all’inizio dell’opera – è interpretata in chiave trionfale più che religiosa e interiore, complici le dinamiche e i tempi sostenuti staccati dal direttore Andriy Yurkevych: una scelta anomala non priva di senso, di cui si è apprezzata l’originalità; ma resta il fatto che le scelte agogiche non sempre hanno convinto appieno: troppo slentati alcuni cantabili, un po’ abbandonati a sé stessi i solisti in taluni ensemble, la cui concertazione è stata un po’ approssimativa. Se la Mosuc, con un’aria finale tesa tra nostalgia e serena accettazione della propria sorte, ha concluso la recita in un meritato trionfo, non da meno è stata la regina antagonista, Silvia Tro Santafé, dotata di
certezza del perdono divino. La preghiera che segue – buona prova del Coro, compatto e coeso quale non lo si era percepito all’inizio dell’opera – è interpretata in chiave trionfale più che religiosa e interiore, complici le dinamiche e i tempi sostenuti staccati dal direttore Andriy Yurkevych: una scelta anomala non priva di senso, di cui si è apprezzata l’originalità; ma resta il fatto che le scelte agogiche non sempre hanno convinto appieno: troppo slentati alcuni cantabili, un po’ abbandonati a sé stessi i solisti in taluni ensemble, la cui concertazione è stata un po’ approssimativa. Se la Mosuc, con un’aria finale tesa tra nostalgia e serena accettazione della propria sorte, ha concluso la recita in un meritato trionfo, non da meno è stata la regina antagonista, Silvia Tro Santafé, dotata di  un’estensione da vero Falcon e di una nota timbrica acida decisamente adeguata al carattere vendicativo di Elisabetta, malcelato nel duetto con Leicester; nell’aria d’esordio le cesellature del cantabile hanno avuto un contraltare nell’accento sapientemente teso della cabaletta. Il ruolo tenorile in quest’opera è ingrato, poiché, essendo irto di difficoltà e non premiato da un’aria solistica, trova più facilità a richiamare su di sé critiche che elogi. Ottima è stata l’interpretazione di Celso Albelo, che si annovera tra i massimi interpreti odierni del repertorio tardo-belcantistico: qualche perplessità lasciata al suo ingresso è stata presto fugata apprezzando, nello stesso duetto con Talbot, la sua capacità di unire alla grazia e alla soavità del tenore leggero il nitore di squillo del lirico; questi tratti,
un’estensione da vero Falcon e di una nota timbrica acida decisamente adeguata al carattere vendicativo di Elisabetta, malcelato nel duetto con Leicester; nell’aria d’esordio le cesellature del cantabile hanno avuto un contraltare nell’accento sapientemente teso della cabaletta. Il ruolo tenorile in quest’opera è ingrato, poiché, essendo irto di difficoltà e non premiato da un’aria solistica, trova più facilità a richiamare su di sé critiche che elogi. Ottima è stata l’interpretazione di Celso Albelo, che si annovera tra i massimi interpreti odierni del repertorio tardo-belcantistico: qualche perplessità lasciata al suo ingresso è stata presto fugata apprezzando, nello stesso duetto con Talbot, la sua capacità di unire alla grazia e alla soavità del tenore leggero il nitore di squillo del lirico; questi tratti,  nei successivi duetti con le regine, hanno dato vita alla profondità, venata di nostalgia e di emozione, con cui l’uomo vive i propri sentimenti d’amore. Tra le seconde parti merita menzione il basso Andrea Concetti (Talbot), non essendosi gli altri segnalati al di sopra di un funzionale comprimariato.
nei successivi duetti con le regine, hanno dato vita alla profondità, venata di nostalgia e di emozione, con cui l’uomo vive i propri sentimenti d’amore. Tra le seconde parti merita menzione il basso Andrea Concetti (Talbot), non essendosi gli altri segnalati al di sopra di un funzionale comprimariato.
Per la componente scenica, il Carlo Felice ha scelto di affidarsi al team che già si era curato del Devereux nel 2016, con Alfonso Antoniozzi in veste di regista, le scene di Monica Manganelli e i costumi di Gianluca Falaschi. Ragioni (comprensibili) di economia hanno evidentemente caratterizzato la produzione, poiché scene e costumi sono stati riciclati in grande misura dall’allestimento di un anno fa. Peccato che si sia pensato di rinnovare il vestiario dei protagonisti, dato che quello di quest’anno è risultato piuttosto stucchevole, e decisamente imbarazzante l’abito di Leicester, via di mezzo tra costume turchesco e vestito muliebre. Abbastanza riciclato anche il concetto registico, con un accenno metateatrale particolarmente evidente all’inizio (le interpreti delle due regine sono raffigurate, durante il preludio, mentre si truccano nei loro camerini, e si scambiano calorosi abbracci ed auguri, quasi a rassicurare il pubblico che le ingiurie con cui si insulteranno appartengono esclusivamente alla finzione scenica) e un proseguimento nel solco della sicura tradizione; scelta che, quando un’opera sia in grado di destare emozioni per la sua musica e i suoi interpreti, non fa gridare all’invenzione geniale del regista ma permette a tutti gli spettatori di gustare lo spettacolo con animo sereno.
Marco Leo

















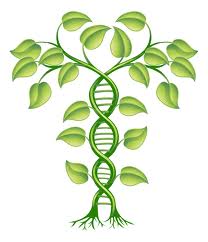





Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *