Ci sono testi della storia del pensiero che dimostrano tutta la loro effettualità nelle più impensate tra le congiunture storico-culturali in cui si trovano ad essere recepiti. Quella in cui viviamo, ad esempio, è una di queste, una congiuntura nella quale riprendere la seconda delle Considerazioni inattuali di F. Nietzsche (1844-1900) può risultare un esercizio
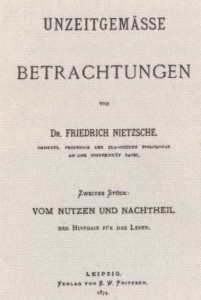 Ci sono testi della storia del pensiero che dimostrano tutta la loro effettualità nelle più impensate tra le congiunture storico-culturali in cui si trovano ad essere recepiti. Quella in cui viviamo, ad esempio, è una di queste, una congiuntura nella quale riprendere la seconda delle Considerazioni inattuali di F. Nietzsche (1844-1900) può risultare un esercizio critico dai risvolti etico-pratici davvero inaspettati e utili, osiamo dire anche necessari. Quelle che andremo chiosando sono le pagine di un giovanissimo professore di filologia classica quale era, almeno da un punto di visto sociologico e professionale, il Nietzsche degli anni di Basilea, che lentamente faceva il suo outing filosofico, declinando la sua attitudine al pensiero come attitudine alla Kulturkritik.
Ci sono testi della storia del pensiero che dimostrano tutta la loro effettualità nelle più impensate tra le congiunture storico-culturali in cui si trovano ad essere recepiti. Quella in cui viviamo, ad esempio, è una di queste, una congiuntura nella quale riprendere la seconda delle Considerazioni inattuali di F. Nietzsche (1844-1900) può risultare un esercizio critico dai risvolti etico-pratici davvero inaspettati e utili, osiamo dire anche necessari. Quelle che andremo chiosando sono le pagine di un giovanissimo professore di filologia classica quale era, almeno da un punto di visto sociologico e professionale, il Nietzsche degli anni di Basilea, che lentamente faceva il suo outing filosofico, declinando la sua attitudine al pensiero come attitudine alla Kulturkritik.
Quello di essere inattuale, ovvero di possedere un sentire e un pensare non misurabile con il metro della propria epoca – è questo il senso letterale dell’aggettivo unzeitgemäβe che campeggia nel titolo di queste Betrachtungen –, fu un’intuizione di sé e del proprio lavoro che Nietzsche portò con sé per quasi tutta la vita, forse fin dentro la follia degli ultimi anni di vita: «[…] questo devo potermelo concedere già per professione, come filologo classico: non saprei infatti che senso avrebbe mai la filologia classica nel nostro tempo, se non quello di agire in esso in modo inattuale – ossia contro il tempo, e in tal modo sul tempo e, speriamolo, a favore di un tempo venturo» (F. Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita, Milano 2009, 4-5).  Questa inattualità, questo suo sconfinare/de-lirare con animo presago oltre i confini della propria epoca, egli la sentì sempre su di sé riversandola con pathos ed ethos straordinari in quelle fisionomie di uomini postumi e uomini cercatori che troviamo descritte nelle opere successive, dallo Zarathustra a La gaia scienza e oltre. Inutile dire quanto questo stile di pensiero e di vita, nutrito di solitudine, erranza, conflitto, abbia rappresentato una forma di profetismo laico di grande fortuna che, se da alcuni fu davvero perseguito con pari se non superiore serietà – «Wer seiner Zeit nur voraus ist, den holt sie einmal ein» diceva l’inattuale Wittgenstein –, da altri fu totalmente frainteso e vissuto come una forma di dandismo velleitario o snobismo à la mode. Chi non ricorda quanti fiori decadenti produsse la diffusione delle opere di Nietzsche in Italia negli anni ‘60 e ’70?.
Questa inattualità, questo suo sconfinare/de-lirare con animo presago oltre i confini della propria epoca, egli la sentì sempre su di sé riversandola con pathos ed ethos straordinari in quelle fisionomie di uomini postumi e uomini cercatori che troviamo descritte nelle opere successive, dallo Zarathustra a La gaia scienza e oltre. Inutile dire quanto questo stile di pensiero e di vita, nutrito di solitudine, erranza, conflitto, abbia rappresentato una forma di profetismo laico di grande fortuna che, se da alcuni fu davvero perseguito con pari se non superiore serietà – «Wer seiner Zeit nur voraus ist, den holt sie einmal ein» diceva l’inattuale Wittgenstein –, da altri fu totalmente frainteso e vissuto come una forma di dandismo velleitario o snobismo à la mode. Chi non ricorda quanti fiori decadenti produsse la diffusione delle opere di Nietzsche in Italia negli anni ‘60 e ’70?.
Eppure in Nietzsche questa inattualità era una conditio sine qua non esistenziale da cui nasceva e in cui si inverava – ambedue i movimenti risultano coessenziali – ogni tentativo di critica della società tedesca del suo tempo. Ci pare di poter dire che per il filosofo di Röcken soltanto il non essere misurabile dalle categorie del proprio tempo e il necessario sconfinare in epoche nuove potevano consentire una critica positiva, effettuale della società. Certamente, anche in Nietzsche, ci fu sempre qualcosa di mitobiografico nel concepire e, di volta in volta, assecondare e perseguire questo ideale, ma viste le realizzazioni letterarie che ne sono venute non si farà fatica a perdonarglielo.
Di queste Unzeitgemäβe Betrachtungen Nietzsche ne scrisse ben quattro. La seconda di esse, oggetto di queste nostre note a margine, riflette Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, ovvero dell’utilità e del danno della storia per la vita, titolo che basterebbe già a dimostrare quanto ingenerosa sia la classificazione di questo scritto a mero manifesto di antistoricismo. In realtà quello di Nietzsche è il tentativo di riconciliare la coscienza storica e l’erudizione su base storica con le esigenze della vita fattuale e di stabilire – in una cultura a forte impianto storicistico come era quella tedesca del XIX – un corretto modo di intendere i rapporti tra storia e vita. In particolare, il problema del rapporto tra sapere storico e forza della prassi del singolo come della collettività: «In essa [nella seconda inattuale] si esporrà […] perché un’istruzione senza vivificazione, perché un sapere in cui l’attività si infiacchisce, perché la storia in quanto preziosa superfluità di conoscenza e in quanto lusso, ci debbano essere sul serio, secondo il detto di Goethe, odiosi – per il fatto cioè che mancano ancora del più necessario, e che il superfluo è nemico del necessario» (Ibidem, 3).
Il fatto che la storia e il sentire storico, ovvero la consapevolezza della genesi storica della realtà, delle idee e della loro interpretazione, fosse necessario per l’azione concreta e che la storia debba servire la vita e, viceversa, la vita la storia costituiva l’intima certezza che mosse Nietzsche a scrivere quelle pagine.
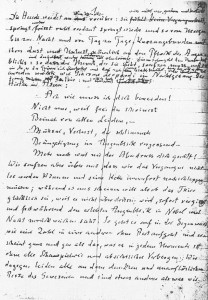 Il tema dei rapporti della storia con la vita ha un primo e intuibile senso in rapporto alla vita personale, alle dinamiche identitarie del soggetto. In questo caso la storia si declina come ricostruzione della memoria, una ricostruzione che è sintesi dell’Historisches – il lavoro storico come la possibilità di ordinare sull’immaginaria linea di un tempo monodirezionale i fatti della propria biografia – e della Geschichktlichkeit – ovvero la storia personale in quanto caricata di un senso o di una plurivocità di sensi che la interpretano –. Nel fondersi di queste prospettive ogni ricostruzione della memoria diventa il linguaggio della propria autocomprensione ultima, diventa identità. Il rischio è quello di non avere un rapporto libero e liberante con la memoria e, quindi, con la propria storia. Si arriva a pensare che il rapporto tra felicità e ricordo e tra felicità e passato sia destinato a un inesorabile cortocircuito. Nelle prime battute del testo Nietzsche, sulla scia di alcuni versi di Leopardi, elogiava la felicità degli animali, i soli, a suo dire, felici perché incapaci di ricordo:
Il tema dei rapporti della storia con la vita ha un primo e intuibile senso in rapporto alla vita personale, alle dinamiche identitarie del soggetto. In questo caso la storia si declina come ricostruzione della memoria, una ricostruzione che è sintesi dell’Historisches – il lavoro storico come la possibilità di ordinare sull’immaginaria linea di un tempo monodirezionale i fatti della propria biografia – e della Geschichktlichkeit – ovvero la storia personale in quanto caricata di un senso o di una plurivocità di sensi che la interpretano –. Nel fondersi di queste prospettive ogni ricostruzione della memoria diventa il linguaggio della propria autocomprensione ultima, diventa identità. Il rischio è quello di non avere un rapporto libero e liberante con la memoria e, quindi, con la propria storia. Si arriva a pensare che il rapporto tra felicità e ricordo e tra felicità e passato sia destinato a un inesorabile cortocircuito. Nelle prime battute del testo Nietzsche, sulla scia di alcuni versi di Leopardi, elogiava la felicità degli animali, i soli, a suo dire, felici perché incapaci di ricordo:
«Osserva il gregge che ti pascola innanzi: esso non sa cosa sia ieri, cosa oggi, salta intorno, mangia, riposa, digerisce, torna a saltare, e così dall’alba al tramonto e di giorno in giorno, legato brevemente con il suo piacere e dolore, attaccato cioè al piuolo dell’istante, e perciò né triste né tediato. Il veder ciò fa male all’uomo, poiché al confronto dell’animale egli si vanta della sua umanità e tuttavia guarda con invidia alla felicità di quello – giacché questo soltanto egli vuole, vivere come l’animale né tediato né fra dolori, e lo vuole però invano, perché non lo vuole come l’animale. L’uomo chiese una volta all’animale: perché non mi parli della tua felicità e soltanto mi guardi? L’animale dal canto suo voleva rispondere e dire: ciò deriva dal fatto che dimentico subito quel che volevo dire – ma subito dimenticò»[1].
Il rapporto infranto con la propria memoria e con la propria biografia personale ed epocale genera questa strana invidia per gli esseri che non ricordano e che coltivano la virtù (apparente) dell’oblio. Il ricordare, allora viene vissuto come un incubo, un peso, un fardello, una zavorra; si cerca di espungerlo dalle proprie possibilità e capacità, ci si impegna a cancellarne i contenuti, a sostituirli con gli “oggi” e gli “ora”, innalzando così la bandiera del presente o tutt’al più del passato prossimo. Non si crede più alla possibilità di collegare ricordo – anche sofferto – e felicità kairologica dell’istante presente, ricordo e inserimento in una prospettiva di futuro. Chi si ostina in questa attitudine negativa verso il proprio passato, chi cerca di mandare all’inferno la propria biografia e chi aggredisce il solo presente ad esso solo chiedendo felicità constata, lentamente ma inesorabilmente, la perdita della propria identità: essa comincia a vacillare, a sfilacciarsi, a perdere la nitidezza dei contorni; la vita esangue mostra il suo pallore, il futuro è mera esposizione a ciò che sarà senza nessun sicuro appoggio su ciò che è stato; una catena infinita di negazioni viene tentata nel vano tentativo di far sparire tutto il pregresso: è la figura evanescente di un uomo senza passato. Nelle parole di Nietzsche: nella vita personale l’assenza di senso storico, ovvero l’assenza di memoria, non permette all’uomo di circoscrivere la propria biografia entro un orizzonte che sia per lui spazio di crescita: «E questa è una legge generale: ogni vivente può diventare sano, forte e fecondo solo entro un orizzonte; se esso è impotente a tracciare un orizzonte intorno a sé, e d’altra parte troppo egocentrico per rinchiudere il suo sguardo in uno estraneo, si avvia in fiacchezza o in concitazione a fine prematura» (Ibidem, 9)
Nietzsche declina in positivo – facendone, appunto, una virtù – gli effetti del senso storico distinguendo tre tipi di storia e ponendola in relazione diretta con tre attitudini del soggetto: in quanto l’uomo «è attivo e ha aspirazioni» avrà bisogno della storia monumentale; in quanto «preserva e venera» di quella antiquaria; in quanto, infine «soffre e ha bisogno di liberazione» una storia critica. Ovviamente sono partizioni dell’unica storia che si riguardano, co-implicano e contrappesano a vicenda, in modo tale – questo Nietzsche lo sa bene e lo ripete in lungo e in largo nella prima parte dello scritto – che l’una non risulti intellegibile e “fruibile” senza l’altra.
La storia, infatti, in quanto monumentum e insieme di monumenta – proprio nel senso con cui la classicità la pratica e la tramanda – offrirà quei «modelli, maestri e consolatori che [l’uomo attivo] non può trovare fra i suoi compagni e nel presente», a patto che la sua attualizzazione non sia un «trapiantare sconsideratamente i vegetali». La storia in quanto antiqua e latrice di antiquitates – cioè in quanto si propone come il negozio antico di un antiquario – è coltivata dall’uomo in quanto vi trova la sua propria origo in prospettiva, a partire quindi dalla storia di ciò che lo circonda. Esemplificando: «La storia della sua città diventa per lui la storia di se stesso; egli concepisce le mura, la porta turrita, l’ordinanza municipale, la festa popolare come un diario illustrato della sua gioventù, e in tutte queste cose ritrova se stesso, la sua forza, la sua diligenza, il suo piacere, il suo giudizio, la sua follia e le sue cattive maniere. Qui si poteva vivere, egli si dice, giacché si può vivere; qui si potrà vivere; giacché siamo tenaci e non ci si può spezzare da un giorno all’altro». Lo storico pratica e gode egli stesso della storia antiquaria in modo tale che l’anima dei secoli passati sia in certo modo la sua stessa anima ma evitando il rischio dell’idolatria che coincide con il rischio di considerarla l’unica sua anima.
Infine, la storia critica che, nelle pagine nietzschiane, si era incontrata si qui solo come il necessario correttivo delle precedenti. Di essa dice essere, inaspettatamente e apparentemente in direzione contraria al ragionamento fatto, quella storia che coincide con il presente colto nella sua necessità di abolire la storia, con la vita colta come forza che si mantiene viva annullando e annullandosi in quanto storia. Una specie, la storia critica, che così Nietzsche descrive: «Egli [l’uomo] deve avere, e di tempo in tempo impiegare, la forza di infrangere e di dissolvere un passato per poter vivere: egli ottiene ciò traendo quel passato innanzi a un tribunale, interrogandolo minuziosamente, e alla fine condannandolo; ogni passato merita invero di essere condannato – giacché così vanno appunto le cose umane […]» (Ibidem, 16-30). La critica è, in fondo, un obliare la storia non per superficialità o smemoratezza ma perché la si è portata davanti al tribunale della ragione – e, ancor più della vita – che ha decretato la necessità del suo oblio, pena la stessa sopravvivenza.
Inutile ribadire o, per i più distratti, proporre una ripresa delle suggestioni nietzschiane quale compito per il nostro tempo. Inutile, poi, decifrare quella congiuntura che rendere quel testo oggi così “inattualmente attuale”, far emergere le diagnosi sul rapporto infranto che la nostra epoca ha con la sua storia non mancano. Eppure «sono questi i servigi che la storia può rendere alla vita; ogni uomo e ogni popolo ha bisogno, secondo le sue mete, forze e necessità, di una certa conoscenza del passato, ora come storia monumentale, ora come storia antiquaria e ora come storia critica» (Ibidem, 30). Anche perché risulta essere una dura legge della storia quella per cui ciò che l’uomo non riesce a fare per virtù propria sarà costretto a farlo incalzato dall’ineluttabilità degli eventi.
Francesco Contento
Note:
1. F. Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita, Milano 2009, 6. La suggestione veniva a Nietzsche dal leopardiano Canto notturno di un pastore errante dell’Asia del 1829 che egli leggeva nella traduzione tedesca di R. Hamerling del 1866. Il testo del poeta di Recanati suonava così: «O greggia mia che posi, oh te beata/ che la miseria tu, credo, non sai!/ Quanta invidia ti porto!/ Non sol perché d’affanno/ quasi libera vai;/ ch’ogni stento, ogni danno,/ ogni estremo timor subito scordi;/ ma più perché giammai tedio non provi./ Quando tu siedi all’ombra, sovra l’erbe,/ tu se’ queta e contenta;/ e gran parte dell’anno/ senza noia consumi in quello stato. /Ed io pur seggo sovra l’erbe, all’ombra,/ e un fastidio m’ingombra/ la mente, ed uno spron quasi mi punge/ sì che, sedendo, più che mai son lunge/ da trovar pace e loco/ […] Se tu parlar sapessi, io chiederei:/ dimmi: perché giacendo/ a bell’agio, ozioso,/ s’appaga ogni animale;/ me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale?» (G. Leopardi, Canti, Torino 1993, 193-194).
[Fonti delle immagini: wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche, wikipedia.org/wiki/Considerazioni_inattuali e freeyourmindfym.wordpress.com]

















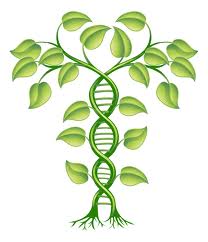





Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *